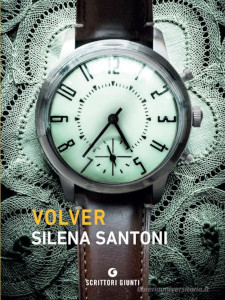Frank McCourt – Le ceneri di Angela (1996)
Ho amato così tanto questo libro da risultarmi difficile non percepire l’inadeguatezza di qualsiasi cosa potrei scriverne.
Potrei iniziare raccontando del suo autore, Francis (Frank) McCourt (1930 – 2009) nato a Brooklyn da genitori irlandesi, cresciuto a Limerick, per poi tornare, non ancora ventenne, nella sua “Terra Promessa”, gli Stati Uniti; di come, dopo una vita intera dedicata all’insegnamento, all’età di sessantasei anni abbia esordito come scrittore con questo capolavoro, “dando un nuovo signficato”, come ebbe a dire un suo intervistatore, “al concetto di fioritura tardiva”.
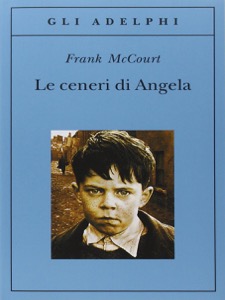
Potrei continuare raccontando dell’incredibile successo editoriale di questo romanzo autobiografico, vincitore del Premio Pulitzer nel 1997, tradotto in trenta lingue, con oltre venti milioni di copie vendute, ben al di là delle aspettative dello stesso McCourt che certo non si aspettava un simile riscontro, piuttosto “brevi e simpatiche recensioni” che avrebbero definito Le Ceneri di Angela “incantevole e lirico, come per lo più avviene con i libri irlandesi di memorie”.
Potrei indugiare sulla trama. Sono gli anni della Grande Depressione e la famiglia McCourt, padre, madre, quattro figli (Frank quattro anni, Malachy tre, i gemellini Oliver e Eugene due) affronta un viaggio di ritorno, potremmo dire “al contrario” da New York a Limerick, all’indomani della morte della piccola Margaret, vissuta solo poche settimane. Un nonsenso, dal momento che le condizioni di vita in Irlanda saranno ancora peggiori di quelle a Brooklyn. Poi il padre alcolizzato, che lotta con i suoi demoni soccombendo ogni volta, la madre, Angela, che il dolore e le privazioni hanno trasformato in un pallido ricordo della ragazza di un tempo; su tutto la miseria assoluta, la fame, la brutalità dell’esistenza delle famiglie nei vicoli della cattolicissima Limerick degli anni Trenta e Quaranta, dove la Chiesa, anziché accogliere, spesso rifiuta i suoi figli più poveri facendo, della loro umile condizione, la loro colpa.
Ancora non avrei detto niente, perché fino a questo punto potremmo a pensare di trovarci di fronte da un triste libro di memorie, in cui sentimentalismo e tragedia si intrecciano in un mix patetico e, in parte, scontato. E’ qui che emerge tutta la straordinarietà del romanzo. La narrazione non è quella del ricordo, tutto ci arriva attraverso gli occhi e i pensieri di Frank bambino, osservatore intelligente e al tempo stesso ingenuo, sensibile ma anche irriverente come solo i ragazzini sanno essere. E il racconto si fa sorprendentemente e irresistibilmente comico, pervaso da vitalità e umorismo contagiosi, sostenuto da uno stile chiaro e diretto, appreso dall’insegnamento, come lo stesso autore dichiarò “Quando parli agli adolescenti devi essere chiaro e diretto perché non hanno pazienza, e per ventisette anni ho dovuto essere chiaro e diretto”.
Così gli eventi, persino quelli più tragici e sconvolgenti, vengono filtrati dal particolare angolo di osservazione di un ragazzino ironico e sognatore, fragile ma al tempo stesso quasi indistruttibile, sostenuto dalla forza d’animo di chi si aggrappa, con tutte le sue forze, alla speranza di poter un giorno ricomiciare là dove tutto è ancora possibile.
E’ un romanzo che non finisce con l’ultima pagina, e non perché McCourt abbia poi raccontato il seguito della sua storia nei successivi due libri, Che paese l’America (1999) e Ehi Prof!! (2005); è un libro che ti rimane addosso, di quelli che, una volta finita la lettura, a malincuore riponi sullo scaffale.